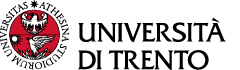Il progetto intende rafforzare e migliorare la qualità della ricerca, della didattica e della terza missione di tutto il Dipartimento, in sinergia con gli obiettivi del PNR e del Progetto strategico di Ateneo. L’obiettivo principale del programma è la razionalizzazione dell’attuale assetto del Dipartimento, che renda possibile un ulteriore innalzamento del suo livello qualitativo, in continuità con il precedente Progetto di eccellenza (P.E.), che ha dato ottimi risultati. Questo significa consolidare (ed estendere alle aree 11 e 14) lo sviluppo e l’avanzamento della qualità della ricerca e della didattica di alta qualificazione ottenuto nel precedente P.E., in un progetto che rafforzi la reputazione internazionale del Dipartimento, ampliando stabilmente la rete delle collaborazioni con soggetti esterni, italiani e stranieri.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si sono individuate cinque strutture strategiche di raccordo, denominate 'Sezioni', che mirano a rafforzare la cooperazione interna tra docenti, Laboratori e Centri. Le Sezioni lavoreranno intorno ad un tema centrale comune: “Reti e percorsi delle culture europee”. Un grande impegno strategico sarà profuso nel rafforzare la capacità di attrazione di nuovi fondi europei e nazionali attraverso bandi competitivi. A tale proposito si segnalano i due Progetti ERC acquisiti nel 2022, che presentano obiettivi e azioni perfettamente coerenti con il P.E. e pertanto contribuiranno in modo rilevante alla realizzazione del progetto. Il Dipartimento intende cofinanziare le azioni di ricerca e di didattica con fondi relativi al Progetto strategico, con fondi per l’internazionalizzazione e per le infrastrutture.
Le azioni programmate prevedono numerose iniziative (programma di visiting professor, summer e winter school, convegni, seminari e workshop rivolti anche ai due corsi di dottorato del Dipartimento, e pubblicazioni) all’interno di reti nazionali e internazionali.
Le sezioni si possono accedere dal menù laterale, oppure cliccando sui seguenti link:
- Codificazioni, Transizioni e Contaminazioni
- Confini e Connessioni
- Conflitti e Riparazioni
- Memorie e Innovazioni
- Tradizioni, Migrazioni e Traduzioni